Un commento Facebook a “Dolore minimo” di Giovanna Cristina Vivinetto.
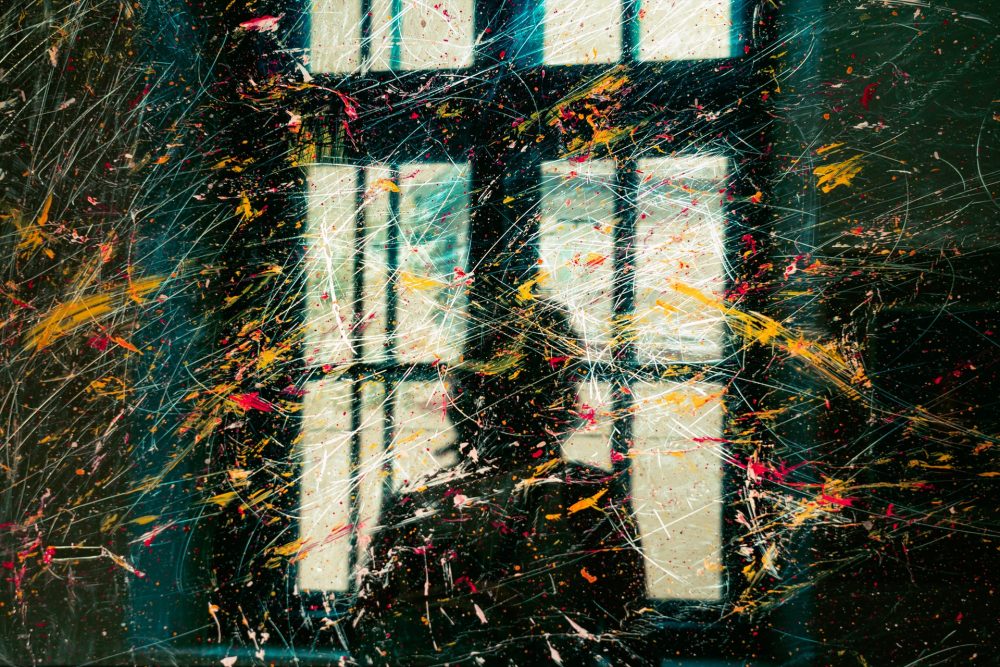
Dolore minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, raccolta poetica uscita per Interlinea, è già un caso letterario alla seconda ristampa che conta numerose menzioni su quotidiani e riviste, rare in fatto di poesia.
Una in particolare, quella del «Fatto Quotidiano» del 31 maggio, è stata ripresa sulla pagina facebook di Pro Vita Onlus in una glossa dura e “punitiva”:
Ci mancava solo che finisse in versi poetici, la transessualità. “Giovanna Vivinetto, studentessa e poetessa di 24 anni, è nata Giovanni”, scrive «Il Fatto Quotidiano» che pubblica le presentazione del suo diario poetico, a cura di Dacia Maraini. “La fatica di essere madre di sé stessa, il difficile compito di partorire un altro da sé che sarà sempre quell’io… vedersi diventare a poco a poco un’altra persona, la gioia, la sorpresa e anche il senso di vuoto di questa nuova nascita”. Vuoto, appunto!
L’attacco sul social è stato diretto, secondo una consolidata tradizione denigratoria, sulla persona e non ha preso di mira l’oggetto letterario in questione. Ripetuto dai difensori e sostenitori dell’autrice commento sotto commento, l’attacco proviene con evidenza da qualcuno che il libro non l’ha neppure sfogliato. Effettivamente gli amministratori della pagina facebook di Pro Vita Onlus non hanno mai avanzato pretese critiche in merito di letteratura e la questione non è, di fatto, d’ordine poetico.
Il post, come la pagina di una raccolta d’Emblemata del Cinquecento, si compone d’immagine e commento: una foto dell’autrice assai ravvicinata – forse un selfie scattato spalle al muro – e la glossa alla recensione apparsa sul «Fatto Quotidiano» pochi giorni prima: immagine e commento, come appunto in una moralizzazione cinquecentesca di miti antichi e non, come ci aspetterebbe, un commento alla copertina o a un estratto del testo.
L’offensiva si scaglia dunque contro i tratti della persona – la sua immagine che ci guarda e si guarda nell’obiettivo – e, come s’intuisce da alcuni dei commenti“pro vita”, contro l’identità – di genere – della scrittrice. La transessualità non sembra poter avere diritto di cittadinanza nella poesia propriamente intesa, secondo il commentatore di facebook, e un certo “vuoto” è attribuito all’identità di questa “nuova nascita”. In altre parole questo vuoto è qui inteso come un’impossibilità e un’illegittimità dell’esistenza. È qui in gioco la vivibilità, nel senso che ne dà Judith Butler, ovvero la garanzia e l’accesso alle libertà e ai beni di prima necessità, di un corpo e di un individuo presente nello spazio pubblico. Eppure nulla nella foto dell’autrice potrebbe turbare una qualsivoglia sensibilità altra, se non le si fosse affiancato un commento, se non le si fosse cucita addosso una identità, se non le si fosse dato un nome. Sulla vita e sul corpo pesa qui il problema d’irriducibilità tra immagine e parola, tra l’apparenza e il linguaggio che la racconta.
In Dolore minimo è raccontata la storia della ricerca e dell’espressione d’identità, la storia di una metamorfosi fondata sulla mutabilità del corpo e sulla sua riconoscibilità. Un evento che si svolge in un bosco come nelle rappresentazioni e nelle favole cinquecentesche nelle quali personaggi come Tiresia, Narciso o Ermafrodito si specchiano in corsi d’acqua, si ricercano nella loro immagine, cambiano forma corporea e mutano di genere. Il bosco che nella poesia del passato – così come il “corpo-bosco” nelle occorrenze della poesia di Vivinetto – è il luogo nel quale si confondono le certezze – dubitare di sé, e del corpo –, nel quale si chiedono chiarezza e intellegibilità al corpo – appellandoci al corpo –; un luogo nel quale diventa difficile dare un nome ai fatti del corpo, o nel quale certi nomi si possono dimenticare e mettere da parte, come parti del corpo in disuso – “i boschi / vergini in cui scordavamo i nomi … Ho l’abitudine di pulire: gli oggetti usati dopo averli comprati. / Mi convinco che l’acqua possa / cancellare la memoria di un uso / improprio e che restituisca / ad ogni cosa la sua giusta luce … Ho imparato l’arte del mettere da parte … parti del corpo in disuso, nomi”.
Dare un nome al proprio corpo, sentirselo nominare, per definirsi e ritrovarsi – “Eravamo solo noi due e il corpo. / Dapprima c’ero io soltanto … nessuno immaginava che sarei / andata nel bosco per ritrovarmi” –, questo accade in questi versi. Questo rapporto d’irriducibilità tra parola e immagine, radicato in profondità nella cultura occidentale, è chiamato in causa qui nella dialettica tra identità e apparenza, tra ciò che si è e ciò che appare, anche e soprattutto agli occhi di “chi ci guarda e di chi ci racconta” per parafrasare un titolo di Adriana Cavarero – perché in fatto d’immagine e costruzione di sé lo sguardo altrui ha un ruolo non marginale. Ed è su questo terreno che il glossatore di facebook muove la sua invettiva moraleggiante di fronte all’immagine dell’autrice. Perché in fondo non è neppure l’autrice l’oggetto preso di mira.
Questa raccolta poetica tocca ed evoca infatti temi che vanno al di là della congiuntura biografica, dell’esperienza individuale, dando al corpo, con la sua mutevolezza d’apparenza e con l’identità che gli attribuisce, il potere di incrinare il binarismo di genere che regola la nostra percezione in fatto d’immagine corporea.
Mi spiegarono la differenza
tra uomo e donna – le caratteristiche
elementari del maschio
e della femmina. Non mi rivelarono però
a quel tempo cosa
si trovasse nel mezzo, all’incrocio
imprevisto tra i due sessi.
Crebbi con una dicotomia nelle ossa
nel perenne adattamento all’una
o all’altra identità.
Solo dieci anni dopo compresi
che esattamente nel mezzo
– indefinita, sfumata, disforica
– c’ero proprio io.
Siamo abituati, ci hanno insegnato sin da piccoli come ricordano questi versi, a discriminare e distinguere con un colpo d’occhio l’aspetto dell’uomo da quello della donna e precisamente in quest’ordine gerarchico: dove l’uomo, l’elemento maschile, è modello di riferimento. La storia delle arti visive lo dimostra molto bene, in quanto costruita antropomorficamente sull’anatomia maschile. Dalle pratiche di bottega di fine Medioevo alle moderne accademie di tutta Europa, generazioni d’artisti e di amatori d’arte si sono formate gli occhi sulla messa in posa del corpo maschile – poi debitamente trasformato se necessario con attributi marcatamente femminili – e con loro il pubblico. Questa solida rassicurante idea di poter vedere e sapere, la radice linguistica greca della nostra cultura accomuna semanticamente vedere e conoscere, permetterebbe di evitare di soffermarsi su ciò che disturba proprio questa nostra certezza binaria: quello che si trova “esattamente nel mezzo, all’incrocio imprevisto tra i due sessi”.
Si dà per scontato che all’aspetto di un individuo corrisponda un determinato sesso e un determinato genere, e quindi una determinata anatomia, anche se la nudità non è mai esibita a tal punto da garantirci la verità della nostra deduzione visiva. Una persona che indossa una gonna sembra coprire un’anatomia strettamente femminile se altri caratteri non vengono a interferire visivamente con questa estensione del corpo – una folta barba che indossa una gonna per esempio. La nominazione effettuata quotidianamente sull’altro – lo nominiamo uomo o la nominiamo donna –, l’assegnazione di genere, si affida alla riconoscibilità di attributi visibili, sulla base dei quali deduciamo una determinata configurazione anatomica, attribuiti questi culturalmente determinati – i teorici dell’intersessualità parlano di “genitali culturali”. L’esistenza di persone intersessuali – alle quali si attribuisce letteralmente un sesso alla nascita – mette in dubbio questa verità che nomina sulla base di una norma anatomica, e Flavia Monceri ha ben descritto questo paradosso di una verità nominabile e nominata che si basa sull’apparenza del “cosa c’è sotto” i cui confini anatomici non sono poi così netti, e di fatto nel nostro quotidiano di scarsa visibilità. Quello che nominiamo come “naturale” è frutto di una naturalizzazione del comune – Everything which is usual appears natural avrebbe detto John Stuart Mill –, di un’elevazione del numerico al rango d’originale, della fede nel dato statistico.
La verità è che i nomi ci scelgono
prima ancora di pronunciarli.
Sulle pareti, a ridosso delle strade,
nei vasi di garofani e ortensie,
…
nelle stazioni in disuso.
Su tutto si coagula
un nome.
…
E chi fugge dai nomi sappia
che non si sfugge alla nominazione
perché i nomi legano in nodi
di verità strette da calzare,
costringono in sillabe da pronunciare
a detti stretti. Da far male.
I nomi che mi hanno scelta
non trovarono angoli da rischiarare.
…
Ci rinunciai e con loro
all’arroganza della definizione.
All’inesattezza di attenersi
alle parole per vedere la realtà”.
L’inesattezza della parola di fronte alla realtà che si vede, evocata da questi versi, pone un problema di riconoscibilità e forse un problema di irriducibilità della parole difronte a ciò che si vede, l’impossibilità di nominare di fronte al fenomeno che non si piega a categorie nette. Ecco la ragione di questa invettiva: l’arroganza della definizione.
Affermare e rivendicare la propria individualità attraverso il proprio corpo e attraverso la poesia è come affermare e rivendicare il diritto di visibilità e quindi di legittimità all’esistenza nello spazio sociale. Diritto reclamato da un corpo che può e potrebbe confondere per la sua apparenza, con la sua immagine corporea, le nostre certezze e mettere in discussione il nostro punto di vista – anche quando come in questo caso l’aspetto non esce davvero dalla norma binaria alla quale tenacemente ci si aggrappa.
La traccia del passaggio – mi dici –
da qui non si vede. Non è evidente.
…
La traccia del passaggio – non la vedi
perché il mio sentiero è troppo
stretto per starci in due.
C’è un punto di vista privilegiato, dal quale si guarda e si nomina, che non trova l’evidenza o la traccia visibile del passaggio tra le due realtà uomo-donna – “da qui non si vede”, si legge in questi versi. Un corpo nato da un passaggio e che in quanto di passaggio apre la possibilità di andare oltre – trans non come tra ma come al di là di – le polarità e il binarismo visivo, confondendo questo stesso privilegio che lo guarda e lo nomina: “credono che la conquista di un corpo / transessuale sia l’alterazione del visibile”, scrive Vivinetto. Un privilegio del vedere, un punto di vista, che giudica moralmente inaccettabile quel soggetto, e quel corpo, che non corrisponde a una norma morale e corporea di lunga tradizione.
Quella che con Cavarero si può chiamare rettitudine, ovvero la qualità distintiva e riassuntiva della soggettività moderna, da Platone passando per Kant, fondata sull’immagine corporea di un corpo e-retto. Dietro all’immaginario geometrico di una verticalità dell’io – grammaticalmente e corporalmente maschile assunto come norma – contrapposto all’inclinazione – tutta femminile non allineata alla verticalità dominante – sta questa idea di rettitudine del soggetto, minacciato da soggetti marginali, quella queerness che convoca e rivendica una soggettività altra, per così dire, decentrata: “ogni inclinazione ci sporge all’esterno, ci porta fuori dall’io”, ci ricorda Hannah Arendt.
Nella verità del post facebook che stiamo guardando, si trovano la foto dell’autrice e le parole che la nominano; di fronte alle parole di chi si sente forte e pieno della propria normalità sta l’immagine del vuoto nel quale risuona armonica la poesia di chi sta ai margini : “esseri normali – sorrido – come / suonano male queste parole”.

